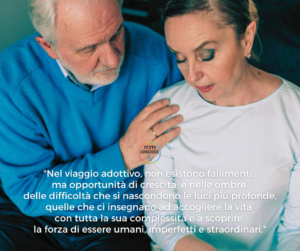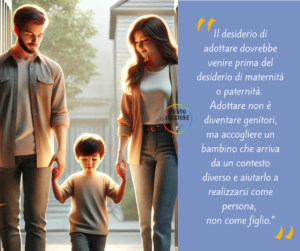Qualche sera fa ho rivisto il film “Philomena” (2013), tratto dal libro di Martin Sixsmith e, a distanza di anni, ho potuto collegare la sua storia ad altre vicende simili, rappresentate successivamente nei libri e al cinema, portandomi a fare alcune riflessioni.
Leggi tutto: Philomena e le madri biologiche: il risvolto dell’adozioneLa storia di Philomena Lee è un esempio emblematico di una pratica crudele e sistematica che ha segnato il destino di molte donne nubili nel XX secolo. Rimasta incinta da adolescente nell’Irlanda cattolica degli anni ’50, Philomena fu rinchiusa in un convento, costretta a partorire in condizioni di umiliazione e, dopo tre anni, privata del suo bambino, dato in adozione a una coppia americana senza il suo consenso. Come molte altre giovani donne, fu obbligata a lavorare per anni nel convento per “espiare il peccato” di essere rimasta incinta fuori dal matrimonio.
Queste pratiche non erano episodi isolati, ma il risultato di un sistema istituzionalizzato che mortificava le donne vulnerabili, sfruttandole in nome di una moralità distorta. Una crudeltà simile emerge anche nel film “Magdalene” (2002) di Peter Mullan, che racconta la vita delle ragazze madri e delle giovani donne costrette a lavorare senza retribuzione nelle lavanderie delle Case Magdalene in Irlanda. Queste strutture, gestite da ordini religiosi, sfruttavano e umiliavano le ospiti. La recente pellicola “Piccole cose come queste”, con Cillian Murphy, affronta nuovamente queste tematiche, evidenziando il trattamento inumano riservato a orfani e ragazze madri nei conventi cattolici, offrendo uno sguardo su come queste ingiustizie abbiano segnato generazioni di donne.
A livello globale, il recente documentario francese “Adozioni internazionali, uno scandalo planetario” porta alla luce casi in cui bambini sono stati sottratti a madri povere in Paesi come Corea del Sud, Sri Lanka, Nepal, Cile e Cina, per alimentare un mercato adottivo internazionale opaco. Tra i Paesi occidentali conniventi figurano Francia, Belgio, Spagna, Danimarca, Olanda, Svezia, Norvegia, Germania, Stati Uniti e Australia. Anche in Italia, nel secondo dopoguerra, molte donne nubili, abbandonate dalle loro famiglie e dalla società, si videro sottrarre i figli, affidati temporaneamente ai brefotrofi, come raccontato nel libro “Il prezzo degli innocenti” di Maria Laurino (2023).
Il filo conduttore di queste vicende è un sistema patriarcale e ipocrita che giudicava le madri biologiche come disfunzionali, senza considerare il contesto di povertà e vulnerabilità in cui si trovavano. Al contempo, si idealizzava il ruolo dei genitori adottivi, ignorando che molti di loro, seppur inconsapevoli, diventavano complici di pratiche ingiuste e a volte non comprendevano davvero il senso di adottare un bambino. Questo punto di vista, ancora oggi diffuso, porta molti genitori adottivi a considerarsi “la scelta migliore” per i bambini, trascurando il diritto delle madri biologiche a essere supportate e non giudicate.
Queste donne, spesso vittime di povertà, discriminazione e mancanza di sostegno, venivano private dei loro figli in modo coercitivo o con inganni, per alimentare un sistema che soddisfacesse la crescente domanda di bambini da adottare nei Paesi ricchi. Infatti, non sempre l’allontanamento o la sottrazione di un bambino era dovuto alla disfunzionalità dei genitori biologici. Una madre non sposata poteva sentirsi troppo giovane, priva di risorse o abbandonata dalla famiglia o dal partner, costretta a compiere scelte dolorose in momenti di estrema fragilità.
Eppure, invece di essere rispettate e aiutate, queste donne venivano umiliate e rese invisibili, pur dando al mondo figli che spesso hanno arricchito la vita di altre famiglie e contribuito alla società.
Chi crea la vita non merita di essere punito in modo così crudele. Le madri biologiche hanno vissuto traumi profondi nel vedersi sottrarre i figli, un evento che ha condizionato irreversibilmente la loro vita. Vergogna, senso di colpa e impotenza sono stati amplificati da un contesto sociale e religioso che le ha stigmatizzate e isolate.
Anche molti adottati portano il peso di queste storie. Il senso di sradicamento, la scoperta di essere stati trattati come “beni da redistribuire”, la difficoltà nel ricostruire le proprie origini e il bisogno di una verità negata incidono profondamente sulla loro identità e sul loro benessere psicologico.
La storia di Philomena, così come quelle delle tante donne protagoniste di questi racconti, offre un’occasione di riflessione amara ma necessaria. Il dibattito odierno sull’adozione deve affrontarne anche gli aspetti oscuri, riconoscendo il dolore e la perdita di chi ha subito queste ingiustizie, mettendo in discussione un sistema che, pur basato su nobili intenzioni, è stato usato per alimentare un giro d’affari miliardario.
Questo dibattito dovrebbe coinvolgere tutti gli attori del mondo adottivo, inclusi i genitori adottivi e le associazioni di riferimento. Tuttavia, spesso si tende a privilegiare una narrazione edulcorata, che oscura le ombre del sistema adottivo e nega il dolore di chi è stato privato dei propri diritti, come le madri biologiche e i bambini adottati. I casi di sottrazione e traffico di minori vengono considerati episodi isolati, non rappresentativi della realtà. Tuttavia, il documentario “Adozioni internazionali, uno scandalo planetario” smonta questa obiezione, dimostrando come il traffico di bambini fosse una prassi sistematica, alimentata dalla domanda crescente di adozioni nei Paesi occidentali.
È stato necessario l’intervento di un gruppo di adottati adulti per portare queste pratiche all’attenzione globale, affinché non si ripetano più. Nel settembre 2023, le Nazioni Unite hanno finalmente accolto il loro invito a discutere delle adozioni illegali, denunciando la falsificazione delle storie delle madri, dei fascicoli personali e dei dossier dei minori, le reti di connivenze e il traffico sistematico di bambini. Nonostante le prove raccolte, nessuno Stato è stato condannato per queste violazioni, tollerate per ragioni politiche ed economiche.
Per costruire una cultura dell’adozione più giusta e consapevole, è fondamentale ascoltare le voci degli adottati e delle madri biologiche, riconoscendone i vissuti e la complessità delle esperienze. Solo così potremo imparare dagli errori del passato e creare un sistema adottivo che rispetti la dignità e i diritti di tutte le parti coinvolte.