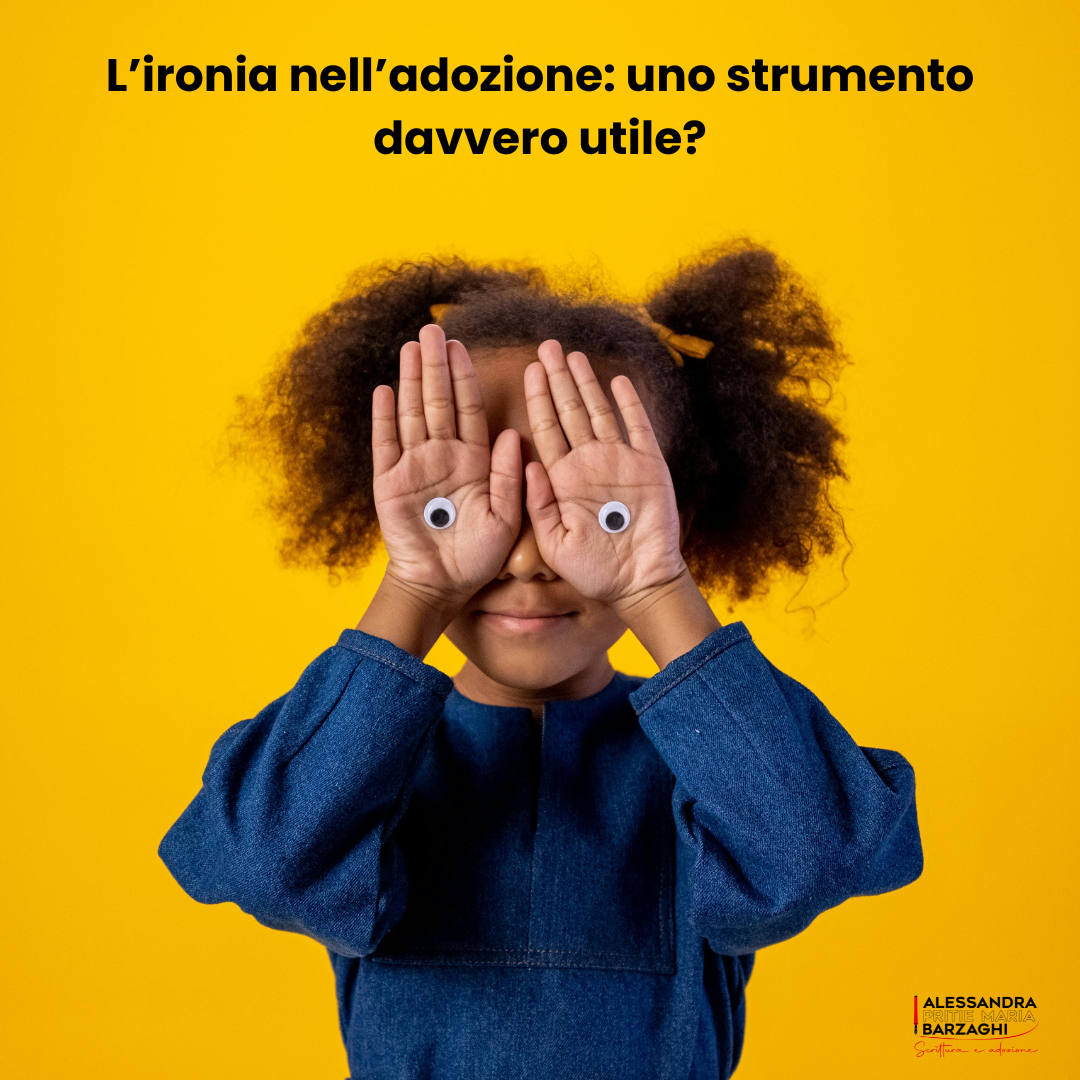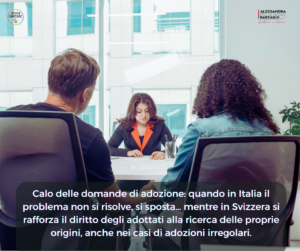Tempo di lettura: 2 minuti
Poco tempo fa, ho partecipato a un seminario sull’adozione che ha offerto spunti interessanti, ma anche momenti di riflessione critica su concetti che, a mio avviso, richiedevano un’analisi più approfondita.
L’idea centrale del seminario era che l’ironia e l’autoironia possano diventare strumenti preziosi per affrontare le difficoltà dell’adozione.
Il relatore ha citato uno studio di Börner, Joseph e Murphy del 2017, che dimostra come l’ironia possa aiutare a gestire le emozioni in situazioni complesse, un approccio che potrebbe effettivamente rivelarsi utile per i genitori adottivi, a volte sovraccaricati da aspettative e preoccupazioni eccessive. Imparare a prendersi meno sul serio e sdrammatizzare alcuni momenti di tensione in famiglia è senza dubbio un esercizio salutare.
Tuttavia, come genitore adottivo, devo ammettere di esserci riuscita di rado, forse anche a causa della mia storia adottiva, che intreccia le due prospettive e mi porta ad avere delle riserve.
È vero che l’umorismo può essere un’ancora di salvezza, ma ritengo che il relatore abbia sottovalutato il fatto che, per molti adottati, su certi vissuti non si possa sorvolare allegramente. L’adozione non rientra tra le normali situazioni che “non possiamo modificare, per cui bisogna imparare a prendersi meno sul serio,” come è stato detto. È una condizione che permea tutta la vita dell’adottato, e la ferita dell’abbandono e la costruzione di una nuova identità sono processi molto più profondi, che richiedono ascolto e accettazione, ben prima di poter essere affrontati con leggerezza.
A volte vedo l’ironia come una forma di rassegnazione, specialmente quando si scherza su situazioni difficili fuori dal nostro controllo, oppure perché siamo poco avvezzi ad accettare la sofferenza, o ancora perché approfondire richiede fatica. Nell’adozione, questo meccanismo rischia di diventare un modo per evitare di affrontare le emozioni più intense legate al trauma e alla perdita subita dal figlio.
Scherzare su ciò che non si può cambiare, per me, riflette a volte un senso di impotenza o diventa una sorta di scudo emotivo, che alleggerisce la tensione ma senza permettere di entrare in contatto con il sentimento sottostante. Capisco che per i “diversamente adottati” usare l’ironia sia un modo per non farsi travolgere dalle emozioni, ma temo che a lungo termine questo approccio possa prendere il sopravvento, impedendo una vera elaborazione dei sentimenti e lasciando questioni irrisolte che si accumulano sotto la superficie.
Per questo, ho poco gradito il reel che è stato proiettato durante la serata, uno sketch di Casa Surace, che ha illustrato bene i limiti dell’umorismo nel contesto adottivo. Se da una parte il tentativo di abbattere gli stereotipi attraverso le gaffe della coppia di amici invitati a cena – digiuni anche di adozione – può essere divertente, e così anche reggere lo scherzo, dall’altra mostrare un ragazzino adottato che gestisce così bene la situazione è forse un’immagine edulcorata della realtà. Il fatto che stia al gioco di due adulti ignoranti mi mette tanta tristezza, per lo scherzo che da copione deve sostenere, forse per far piacere ai genitori, nonostante la sua esperienza drammatica. I bambini adottati portano con sé ferite profonde, confusione emotiva e difficoltà cognitive, ed è necessario riconoscerle con onestà, senza idealizzare le loro reazioni.
Quando ci si rassegna a scherzare su queste ferite, si potrebbe trasmettere l’idea che sia meglio non affrontarle a fondo, lasciandole irrisolte. Questo potrebbe allontanare la possibilità di creare con il figlio spazi di dialogo autentico e aperto, dove il dolore e le emozioni complesse possono essere riconosciute ed elaborate senza maschere.
Nel corso del seminario sono emerse alcune affermazioni che meritano un esame critico. Il relatore ha descritto l’adozione come “l’ultima possibilità per avere un figlio” per le coppie infertili, e l’ha giustamente presentata come un dato di fatto, poiché la stragrande maggioranza di chi adotta lo fa perché non può generare. Tuttavia, sarebbe stato più opportuno sottolineare che, in realtà, l’adozione dovrebbe essere un percorso scelto con consapevolezza. Descriverla in quel modo rischia di perpetuare e legittimare l’idea che sia giusto considerare l’adozione come un ‘piano B’.
In un altro passaggio critico, il relatore ha affermato che gli assistenti sociali dovrebbero dire ai genitori adottivi di raccontare ai figli che i loro genitori biologici “non erano capaci di fare i genitori.” Questa affermazione mi ha lasciato perplessa. Ridurre le cause dell’adozione a una semplice incapacità genitoriale senza tener conto di molteplici altri fattori è fuorviante.
Anche la visione del relatore sulla resilienza dei bambini adottati ha suscitato in me perplessità. Certamente, un certo numero di adottati riesce nel tempo a convivere con le esperienze avverse del passato e a costruire una vita serena, ma non dovremmo mai dare per scontato che siano in grado di “superare” il trauma, quanto piuttosto di lenirlo.
Definire un bambino adottato “un reduce da una grande guerra” è forse l’unica parte della sua riflessione che coglie la complessità del vissuto adottivo. Tuttavia, abbinarvi il concetto di orgoglio come antidoto al dolore rischia di mettere sugli adottati una pressione emotiva eccessiva: devono essere “orgogliosi” della loro capacità di superare, ma a che costo?
A mio avviso, l’ironia e l’autoironia possono essere strumenti utili, ma vanno maneggiate con cura, specie nel contesto dell’adozione. Se applicate con superficialità, rischiano di diventare un modo per evitare il confronto con i sentimenti più profondi di dolore e perdita.
Ciò che è mancato nel seminario è un riconoscimento più sincero delle complessità emotive degli adottati. Chissà, forse verrà dedicato un secondo appuntamento a questo tema e magari verrà specificato che la leggerezza nell’adozione può essere uno “strumento salvifico” solo quando è accompagnata da una piena consapevolezza della sua realtà.
Avvertenza: Le opinioni e i punti di vista espressi negli articoli presenti su questo sito riflettono esclusivamente il pensiero dell’autrice, Alessandra Pritie Maria Barzaghi. Tutti i contenuti sono pensati per offrire spunti di riflessione utili e interessanti, e momenti di approfondimento su tematiche adottive, e non hanno finalità di consulenza psicologica, medica o legale. La riproduzione dei materiali presenti in questo sito è consentita solo previa autorizzazione scritta dell’autrice.