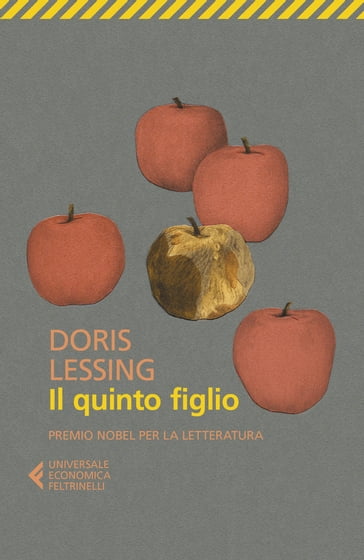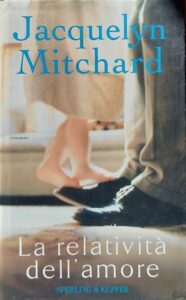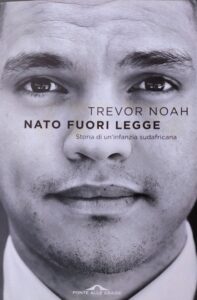Tempo di lettura: 2 minuti
Ho appena finito di leggere il libro “Il quinto figlio” di Doris Lessing, Premio Nobel per la Letteratura. È un romanzo che scava nelle pieghe più profonde delle dinamiche familiari, sfidandoci a riflettere su temi universali come la felicità, la diversità e la sofferenza.
Leggi tutto: Il quinto figlioL’incontro tra la storia di Harriet e David, protagonisti della vicenda, e la mia esperienza nell’adozione mi ha offerto anche uno spunto interessante per mettere a confronto l’idea di una perfezione familiare e le aspettative che spesso accompagnano il ruolo genitoriale.
L’ho trovato a tratti disturbante, soprattutto nel modo in cui viene descritto Ben, il quinto figlio di Harriet e David, e nel fatto che viene isolato dalla sua famiglia semplicemente perché diverso. Ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la decisione di Harriet di tenerlo non per imparare ad amarlo, ma per cercare di capire perché fosse nato così, come se il suo stesso figlio fosse un enigma da risolvere piuttosto che una persona da accogliere. Nella mia esperienza, questo “approccio scientifico” ricorre spesso nella genitorialità adottiva: perché si comporta così?
La situazione descritta nel romanzo mi ha indotto a una serie di riflessioni profonde sul concetto di diversità, sull’accettazione e, soprattutto, su quanto sia fragile l’idea di una felicità programmata e imposta.
Harriet e David, con la loro visione di una famiglia numerosa e felice, incarnano un’idea di felicità radicata profondamente nella mentalità occidentale e cattolica, dove si aspira a un futuro sereno e privo di problemi. La loro è una felicità “pretesa”, un progetto di vita deciso a tavolino, come se la felicità fosse una meta garantita, purché si segua un piano ben preciso. Comprano una grande villa, hanno figli uno dopo l’altro, e costruiscono un idillio familiare che sembra risolvere ogni problema, proprio perché lo hanno voluto così. Il loro tradizionalismo sfida le convenzioni degli anni Sessanta, e nonostante la mancanza di approvazione esterna, sono convinti di poter creare una vita perfetta semplicemente decidendolo.
L’arrivo del quinto figlio, Ben, sconvolge questo fragile equilibrio. Già durante la gravidanza, Harriet percepisce che qualcosa in lui è diverso, il feto sferra pugni nel suo ventre, è quasi un alieno. Quando nasce, Ben si rivela una presenza inquietante: con la sua forza sovrumana, l’aspetto neandertaliano e la mancanza di empatia, diventa immediatamente un elemento destabilizzante per la famiglia. Harriet e David, come molti genitori adottivi, si trovano ad affrontare una realtà ben diversa dalle loro aspettative.
La diversità di Ben non è solo fisica, ma rappresenta la rottura dell’illusione dei genitori di poter controllare la vita e i suoi risultati. Ben viene descritto come freddo, distaccato, non va bene a scuola, è aggressivo e guarda i suoi fratelli con occhi gelidi, senza mai dimostrare affetto per i genitori. Crescendo, frequenta cattive compagnie, e Harriet arriva a sospettare che possa essere addirittura un capobanda pericoloso. Questa descrizione del personaggio di Ben rafforza il senso di estraneità che la sua famiglia prova nei suoi confronti, creando una frattura sempre più profonda.
In un certo senso, l’esperienza di accogliere Ben può essere paragonata a quella di un genitore adottivo che si trova a fare i conti con un figlio che non corrisponde alle aspettative iniziali. Spesso, i figli adottivi portano con sé un bagaglio di esperienze traumatiche, difficoltà emotive o differenze culturali che richiedono un percorso di accettazione e comprensione profondo da parte della famiglia. Come nel caso di Ben, la diversità può generare paure, distanze e difficoltà relazionali. Nel romanzo, la mancata accettazione di Ben porta alla sua emarginazione e isolamento. Nella realtà adottiva, la mancata comprensione e accoglienza delle differenze può generare tensioni simili, con il rischio di rendere il figlio adottivo un outsider all’interno della propria famiglia.
Nella genitorialità adottiva, i genitori sono chiamati a un percorso di consapevolezza e crescita, che prevede l’accettazione non solo del figlio, ma anche dei propri limiti e fallibilità. Così come Harriet è tormentata da un profondo senso di colpa per aver voluto così tanti figli e per aver dato alla luce un bambino che sconvolge la vita di tutti, nella genitorialità adottiva, il senso di colpa può emergere quando i genitori si sentono inadeguati o colpevoli per non riuscire a creare quel legame affettivo che avevano sperato, sentendosi impotenti di fronte alle difficoltà del figlio.
La pretesa di Harriet e David di poter essere felici “perché lo avevano deciso” si scontra inevitabilmente con la realtà della vita. Harriet, distrutta dall’incomprensibilità di Ben, riflette con amarezza: “Questa è una punizione… Per aver voluto troppo. Per aver pensato di essere felici. Felici perché l’avevamo deciso.” Qui, Lessing ci mette di fronte a una verità spesso ignorata: non possiamo decidere di essere felici solo perché lo vogliamo. Il destino, con le sue incertezze e sofferenze, si fa strada nei nostri piani, ricordandoci che la vita non segue il copione che abbiamo scritto.
Nel riscrivere il finale del romanzo, Lessing fa emergere con forza questo concetto: nella prima versione, la conclusione era troppo “buonista”, come se i protagonisti potessero sfuggire alle conseguenze delle loro scelte. Ma nella versione definitiva, la coppia viene “punita” per aver osato sfidare il destino, per aver preteso una felicità che non poteva essere imposta. Nessuno è felice a questo mondo, sembra dirci l’autrice, e la sofferenza è parte integrante della vita. Questa riflessione si applica anche alla genitorialità adottiva: l’adozione non è una soluzione magica ai problemi, né un percorso lineare verso la felicità. È un viaggio fatto di sfide, in cui la sofferenza e la gioia convivono, e in cui l’amore non è immediato o garantito, ma richiede tempo, comprensione e, soprattutto, la capacità di accogliere il figlio con tutte le sue complessità.